COSENZA – Quando meno te lo aspetti, ti fermi, ti crolla la terra da sotto i piedi. In mezzo a quelli che hanno consegnato questa città alle destre, ci sono gli stessi che ci hanno sempre visto come fumo negli occhi. Dovevamo lasciarli lavorare, dicevano. Se non ci muoviamo subito, lo spazio dell’opposizione verrà riguadagnato da qualche traffichino di partito
Cosenza così vicina così lontana – 1
Un signore con la barba, nato a Treviri ma vissuto da clandestino a Parigi e Londra per gran parte della sua vita, scrisse una volta: «L’esigenza di abbandonare le illusioni sulla propria condizione è l’esigenza di abbandonare una condizione che ha bisogno di illusioni».
Noi migranti ne sappiamo qualcosa, di illusioni da abbandonare. Abbiamo spesso una visione distorta del luogo da cui siamo partiti. In genere, conserviamo un ricordo idilliaco della terra d’origine. A volte, nel bel mezzo della sospensione temporale e spaziale in cui si trova la nostra coscienza, confondiamo le cose. Così, può capitare che uno mescoli le coordinate e che senza volerlo viaggi oltre le dimensioni conosciute. Potrei raccontare centinaia di esempi. La panchina di Loreto di venti anni fa – ad esempio – qualche mese fa si è spostata nel centro storico di Perugia, dove ho ascoltato Astolfo e Gianmarco (altri due esuli) parlare della storia di «Cipparrone che pareva Schuster» e di altri giocatori del Cosenza degli anni ottanta. La chitarra di Toniupunk, poche settimane fa, ha incrociato a Roma l’abbraccio verace di Billy Bragg, il menestrello operaio britannico. «Billy, questo è il BillyBragg della mia città», ho detto presentandogli Toni. «E’ vero, abbiamo lo stesso naso!», ha risposto Billy senza esitare. Era uno di noi. Così, la vilienza di UmbertoSpider adesso occupa lo spazio di una libreria nel quartiere radicalchic del Pigneto. Oppure, l’esperienza al bancone di Wladimir (eufemismo) è servita a rimettere a nuovo un bar al Pratello. È come se Bologna – quel pezzo di Bologna che ha ospitato Radio Alice, i partigiani, i ladri e le puttane – si fosse spostata al Bar Mazzini.
Insomma, è un gran casino. All’improvviso – quando meno te lo aspetti – ti fermi, ti crolla la terra da sotto i piedi e se sei a Cosenza ti senti proiettato qualche centinaia di chilometri più in là, e viceversa. Questa condizione contiene delle scomodità, ma offre anche dei vantaggi. Ci muoviamo sulle stesse frequenze delle moltitudini in movimento. Così, può capitare che tra gli scaffali dell’alimentari bengalese sotto casa mia, a Tor Pignattara, si discuta delle elezioni presidenziali in India. E può anche succedere che i tanti compagni inebriati dalla sconfitta del berlusconismo nella sua capitale (im)morale ti chiedano conto di quello che succede a Cosenza.
Da questa confusione in cui vi ho fatto precipitare, mi viene in mente una frase in inglese: «We’ve got a bigger problem now». «Adesso abbiamo un problema più grande». È il verso di una canzone dei DeadKennedys che annuncia il tempo dell’elezione di Ronald Reagan, cioè l’inizio della grande restaurazione negli Stati uniti dopo il movimento contro la guerra e quello dei diritti civili. Anche Jello Biafra, il cantante di quella band, era un fuorisede. Veniva dal Colorado e si era stabilito a San Francisco, in California. Probabilmente in quando non autoctono, aveva lo sguardo giusto sulla situazione dello stato americano, perché nel 1979, scrisse «California Über Alles» una canzone che molti di voi conosceranno. Quella canzone è una beffa doppia. Spara sul potere e contemporaneamente si prende gioco del mito libertario, artistoide e un po’ fricchettone della California, si prende la briga di annunciare i tempi in cui regna una nuova forma di autoritarismo molto hippie. Chi non veste alla moda verrà ucciso da gas velenosi ma biologici, cioè conformi al politicamente corretto. Alla vostra porta busseranno poliziotti che indossano rassicuranti divise in tessuto scamosciato. A scuola i vostri figli verranno rieducati, ma attraverso la pratica esotica della meditazione. Molti pensarono a una provocazione. Non poteva accadere nello stato più libertario degli Stati uniti: cosa voleva questo bifolco del Colorado? E invece Jello Biafra aveva ragione. Nel 1982 dalla California prese il volo il presidente Ronald Reagan. Il pistolero del cinema hollywodiano si stabilì alla Casa Bianca e cominciò il neoliberismo. Jello Biafra riscrisse «California Über Alles» intitolandola, come dicevo prima, «Adesso abbiamo un problema più grande».
Bene, cari compagni e compagne, io penso che qui a Cosenza oggi, dopo gli anni della normalizzazione della vita politica e dopo il tentativo ordito dal lato oscuro di questa città di mandare in galera alcuni nostri fratelli e sorelle, adesso abbiamo un problema più grande. Ovviamente, se qualcuno pensa che siamo arrivati fino a questo punto, dopo molti anni e tante cose messe in piedi, per starcene buoni nei nostri ghetti ad aspettare che la presunta “normalità” venga ristabilita, si sbaglia di grosso. In mezzo a quelli che hanno consegnato questa città alle destre, ci sono gli stessi che ci hanno sempre visto come fumo negli occhi. Dovevamo lasciarli lavorare, dicevano. Inarcavano il sopracciglio e ci spiegavano che la politica era affare loro. Dicevano che eravamo pericolosi terroristi quando gli tiravamo in faccia le torte. Volevano avere campo libero. Mandavano personaggi improbabili ad origliare le nostre assemblee pubbliche. Si è visto dove ci hanno portato, questi cialtroni tenaci e spietati. Gli affari sporchi, i tatticismi e le manovre di palazzo, i veleni biologici contro chi cercava di costruire un’altra politica, sono serviti solo a consegnare la città, per la prima volta nella sua storia recente, alle destre.
Adesso invece dobbiamo dire chiaro che sono loro che devono lasciarci lavorare. Siamo noi, con le diverse storie e le culture che ci portiamo dietro, che abbiamo il compito di fare un passo in avanti, di camminare insieme oltre i nostri recinti per riempire il vuoto lasciato dai partiti del centrosinistra.
Non c’è molto tempo. In politica gli spazi vuoti non rimangono mai liberi, vengono occupati come fossero vasi comunicanti. Se non ci muoviamo subito, lo spazio dell’opposizione alla destra, che è tutt’ora maggioritario in questa città verrà riguadagnato da qualche traffichino di partito. O magari anche dalle nostre parti avranno fortuna i seguaci della setta di quel Capo-Comico con la barba che in questi anni ha succhiato come un parassita i temi faticosamente elaborati dai movimenti dal basso, e che sostiene che i calabresi sono corrotti perché «è il loro carattere» e che straparla di «invasione di extracomunitari» proprio come Bossi.
Potremmo affrontare questa situazione partendo dalla nostra rabbia e dalle nostre frustrazioni. Invece, la cara vecchia saggezza dei movimenti ci suggerisce che c’è un’altra strada da percorrere. Quando si rischia di essere chiusi all’angolo, bisogna alzare il tiro. Nel nostro caso, alzare il tiro significa giocare al rialzo. Cioè porsi direttamente non solo il problema di Occhiuto e di Cosenza ma di Scopelliti e della Calabria. In questo modo la nostra città, che ha qualche esperienza in più di mobilitazione e una tradizione più forte alle spalle, può mettersi al centro di un dibattito più ampio che deve diventare regionale per assediare davvero i palazzi del potere.
Sarebbe bello, ad esempio, che qualcuno venisse da Reggio Calabria a raccontare ai cosentini come funziona il modello Scopelliti, che sta per sbarcare anche in riva al Crati. Una prospettiva regionale delle nostre azioni, sarebbe anche un’ottima maniera per liberarsi delle illusioni sulla Cosenza «isola felice» e «città sovversiva», che ormai da qualche anno costituivano più un mantra auto-assolutorio che energia positiva. Era una cantilena, quella dell’«isola felice», tanto più pericolosa quanto più basata su dati oggettivi e reali che costituivano la nostra specificità locale. Ma bisogna anche dire che quella «narrazione», per usare un termine di moda, non corrispondeva alla vita di tutti i giorni. La nostra Cosenza oggi, come la California dei Dead Kennedys alla fine degli anni settanta, rimastica storie di un’era che non esiste. Sono storie rassicuranti ma poco produttive. Bisogna dire chiaramente che oggi abbiamo un problema più grande. Quel problema, per molti aspetti, è lo stesso problema che hanno i reggini, i catanzaresi e i calabresi tutti. Quel problema si chiama Scopelliti, è legato al malgoverno e al malaffare del presidente della regione, ex fascista che un tempo – da segretario del Fronte della gioventù – se la dava a gambe quando provava a parlare all’Università della Calabria. Scopelliti adesso, come la maggior parte dei suoi camerati, è passato armi e bagagli nel partito di Berlusconi e Dell’Utri. Soltanto sollevando quel problema, facendolo vivere nelle nostre vertenze e nelle esperienze di auto-governo che hanno bisogno di essere messe in rete, avremmo gioco facile nello sbugiardare la destra, che ha usato un sedicente «centrista» come testa di ponte per espugnare Cosenza e che vorrebbe piegarla definitivamente al fascismo-zen della propaganda televisiva e delle clientele.
Lo scrittore belga Jean Améry, come Primo Levi si suicidò dopo essere stato in un campo di concentramento e aver partecipato alla Resistenza. Amery racconta un aneddoto accaduto nel 1943, quando condivideva un appartamento coi suoi compagni partigiani. L’abitazione era confinante con una casa abitualmente frequentata da soldati nazisti. Un giorno, il rumore dei ribelli disturba la pennichella pomeridiana di un soldato, dall’altra parte del pianerottolo. Allora quest’ultimo sale e, trafelato e ancora mezzo addormentato, invoca un po’ di quiete. Scrive Amery/Mayer: «La sua protesta – e per me questo fu il lato realmente spaventoso della vicenda – avvenne nel dialetto della mia regione. Da molto tempo non avevo più udito quella cadenza e questo suscitò in me il folle desiderio di rispondergli nel suo stesso dialetto. Mi trovavo in una disposizione paradossale, quasi perversa, fatta di enorme paura e al contempo di improvvisa, familiare cordialità, perché quel tizio […] mi apparve d’un tratto come un familiare compagno. Non sarebbe stato sufficiente apostrofarlo nella sua, nella mia lingua, per poi celebrare tra compatrioti con una bottiglia di buon vino una festa di riconciliazione?». La morale della favola dovremmo ormai averla imparata sulla nostra pelle: anche tra chi parla il nostro stesso dialetto si nasconde un boia.
Giuliano Santoro
Il dialetto familiare che nasconde un boia!
COSENZA – Quando meno te lo aspetti, ti fermi, ti crolla la terra da sotto i piedi. In mezzo a quelli che hanno consegnato questa città alle destre, ci sono gli stessi che ci hanno sempre visto come fumo negli occhi. Dovevamo lasciarli lavorare, dicevano. Se non ci muoviamo subito, lo spazio dell’opposizione verrà riguadagnato da qualche traffichino di partito
Cosenza così vicina così lontana – 1
Un signore con la barba, nato a Treviri ma vissuto da clandestino a Parigi e Londra per gran parte della sua vita, scrisse una volta: «L’esigenza di abbandonare le illusioni sulla propria condizione è l’esigenza di abbandonare una condizione che ha bisogno di illusioni».
Noi migranti ne sappiamo qualcosa, di illusioni da abbandonare. Abbiamo spesso una visione distorta del luogo da cui siamo partiti. In genere, conserviamo un ricordo idilliaco della terra d’origine. A volte, nel bel mezzo della sospensione temporale e spaziale in cui si trova la nostra coscienza, confondiamo le cose. Così, può capitare che uno mescoli le coordinate e che senza volerlo viaggi oltre le dimensioni conosciute. Potrei raccontare centinaia di esempi. La panchina di Loreto di venti anni fa – ad esempio – qualche mese fa si è spostata nel centro storico di Perugia, dove ho ascoltato Astolfo e Gianmarco (altri due esuli) parlare della storia di «Cipparrone che pareva Schuster» e di altri giocatori del Cosenza degli anni ottanta. La chitarra di Toniupunk, poche settimane fa, ha incrociato a Roma l’abbraccio verace di Billy Bragg, il menestrello operaio britannico. «Billy, questo è il BillyBragg della mia città», ho detto presentandogli Toni. «E’ vero, abbiamo lo stesso naso!», ha risposto Billy senza esitare. Era uno di noi. Così, la vilienza di UmbertoSpider adesso occupa lo spazio di una libreria nel quartiere radicalchic del Pigneto. Oppure, l’esperienza al bancone di Wladimir (eufemismo) è servita a rimettere a nuovo un bar al Pratello. È come se Bologna – quel pezzo di Bologna che ha ospitato Radio Alice, i partigiani, i ladri e le puttane – si fosse spostata al Bar Mazzini.
Insomma, è un gran casino. All’improvviso – quando meno te lo aspetti – ti fermi, ti crolla la terra da sotto i piedi e se sei a Cosenza ti senti proiettato qualche centinaia di chilometri più in là, e viceversa. Questa condizione contiene delle scomodità, ma offre anche dei vantaggi. Ci muoviamo sulle stesse frequenze delle moltitudini in movimento. Così, può capitare che tra gli scaffali dell’alimentari bengalese sotto casa mia, a Tor Pignattara, si discuta delle elezioni presidenziali in India. E può anche succedere che i tanti compagni inebriati dalla sconfitta del berlusconismo nella sua capitale (im)morale ti chiedano conto di quello che succede a Cosenza.
Da questa confusione in cui vi ho fatto precipitare, mi viene in mente una frase in inglese: «We’ve got a bigger problem now». «Adesso abbiamo un problema più grande». È il verso di una canzone dei DeadKennedys che annuncia il tempo dell’elezione di Ronald Reagan, cioè l’inizio della grande restaurazione negli Stati uniti dopo il movimento contro la guerra e quello dei diritti civili. Anche Jello Biafra, il cantante di quella band, era un fuorisede. Veniva dal Colorado e si era stabilito a San Francisco, in California. Probabilmente in quando non autoctono, aveva lo sguardo giusto sulla situazione dello stato americano, perché nel 1979, scrisse «California Über Alles» una canzone che molti di voi conosceranno. Quella canzone è una beffa doppia. Spara sul potere e contemporaneamente si prende gioco del mito libertario, artistoide e un po’ fricchettone della California, si prende la briga di annunciare i tempi in cui regna una nuova forma di autoritarismo molto hippie. Chi non veste alla moda verrà ucciso da gas velenosi ma biologici, cioè conformi al politicamente corretto. Alla vostra porta busseranno poliziotti che indossano rassicuranti divise in tessuto scamosciato. A scuola i vostri figli verranno rieducati, ma attraverso la pratica esotica della meditazione. Molti pensarono a una provocazione. Non poteva accadere nello stato più libertario degli Stati uniti: cosa voleva questo bifolco del Colorado? E invece Jello Biafra aveva ragione. Nel 1982 dalla California prese il volo il presidente Ronald Reagan. Il pistolero del cinema hollywodiano si stabilì alla Casa Bianca e cominciò il neoliberismo. Jello Biafra riscrisse «California Über Alles» intitolandola, come dicevo prima, «Adesso abbiamo un problema più grande».
Bene, cari compagni e compagne, io penso che qui a Cosenza oggi, dopo gli anni della normalizzazione della vita politica e dopo il tentativo ordito dal lato oscuro di questa città di mandare in galera alcuni nostri fratelli e sorelle, adesso abbiamo un problema più grande. Ovviamente, se qualcuno pensa che siamo arrivati fino a questo punto, dopo molti anni e tante cose messe in piedi, per starcene buoni nei nostri ghetti ad aspettare che la presunta “normalità” venga ristabilita, si sbaglia di grosso. In mezzo a quelli che hanno consegnato questa città alle destre, ci sono gli stessi che ci hanno sempre visto come fumo negli occhi. Dovevamo lasciarli lavorare, dicevano. Inarcavano il sopracciglio e ci spiegavano che la politica era affare loro. Dicevano che eravamo pericolosi terroristi quando gli tiravamo in faccia le torte. Volevano avere campo libero. Mandavano personaggi improbabili ad origliare le nostre assemblee pubbliche. Si è visto dove ci hanno portato, questi cialtroni tenaci e spietati. Gli affari sporchi, i tatticismi e le manovre di palazzo, i veleni biologici contro chi cercava di costruire un’altra politica, sono serviti solo a consegnare la città, per la prima volta nella sua storia recente, alle destre.
Adesso invece dobbiamo dire chiaro che sono loro che devono lasciarci lavorare. Siamo noi, con le diverse storie e le culture che ci portiamo dietro, che abbiamo il compito di fare un passo in avanti, di camminare insieme oltre i nostri recinti per riempire il vuoto lasciato dai partiti del centrosinistra.
Non c’è molto tempo. In politica gli spazi vuoti non rimangono mai liberi, vengono occupati come fossero vasi comunicanti. Se non ci muoviamo subito, lo spazio dell’opposizione alla destra, che è tutt’ora maggioritario in questa città verrà riguadagnato da qualche traffichino di partito. O magari anche dalle nostre parti avranno fortuna i seguaci della setta di quel Capo-Comico con la barba che in questi anni ha succhiato come un parassita i temi faticosamente elaborati dai movimenti dal basso, e che sostiene che i calabresi sono corrotti perché «è il loro carattere» e che straparla di «invasione di extracomunitari» proprio come Bossi.
Potremmo affrontare questa situazione partendo dalla nostra rabbia e dalle nostre frustrazioni. Invece, la cara vecchia saggezza dei movimenti ci suggerisce che c’è un’altra strada da percorrere. Quando si rischia di essere chiusi all’angolo, bisogna alzare il tiro. Nel nostro caso, alzare il tiro significa giocare al rialzo. Cioè porsi direttamente non solo il problema di Occhiuto e di Cosenza ma di Scopelliti e della Calabria. In questo modo la nostra città, che ha qualche esperienza in più di mobilitazione e una tradizione più forte alle spalle, può mettersi al centro di un dibattito più ampio che deve diventare regionale per assediare davvero i palazzi del potere.
Sarebbe bello, ad esempio, che qualcuno venisse da Reggio Calabria a raccontare ai cosentini come funziona il modello Scopelliti, che sta per sbarcare anche in riva al Crati. Una prospettiva regionale delle nostre azioni, sarebbe anche un’ottima maniera per liberarsi delle illusioni sulla Cosenza «isola felice» e «città sovversiva», che ormai da qualche anno costituivano più un mantra auto-assolutorio che energia positiva. Era una cantilena, quella dell’«isola felice», tanto più pericolosa quanto più basata su dati oggettivi e reali che costituivano la nostra specificità locale. Ma bisogna anche dire che quella «narrazione», per usare un termine di moda, non corrispondeva alla vita di tutti i giorni. La nostra Cosenza oggi, come la California dei Dead Kennedys alla fine degli anni settanta, rimastica storie di un’era che non esiste. Sono storie rassicuranti ma poco produttive. Bisogna dire chiaramente che oggi abbiamo un problema più grande. Quel problema, per molti aspetti, è lo stesso problema che hanno i reggini, i catanzaresi e i calabresi tutti. Quel problema si chiama Scopelliti, è legato al malgoverno e al malaffare del presidente della regione, ex fascista che un tempo – da segretario del Fronte della gioventù – se la dava a gambe quando provava a parlare all’Università della Calabria. Scopelliti adesso, come la maggior parte dei suoi camerati, è passato armi e bagagli nel partito di Berlusconi e Dell’Utri. Soltanto sollevando quel problema, facendolo vivere nelle nostre vertenze e nelle esperienze di auto-governo che hanno bisogno di essere messe in rete, avremmo gioco facile nello sbugiardare la destra, che ha usato un sedicente «centrista» come testa di ponte per espugnare Cosenza e che vorrebbe piegarla definitivamente al fascismo-zen della propaganda televisiva e delle clientele.
Lo scrittore belga Jean Améry, come Primo Levi si suicidò dopo essere stato in un campo di concentramento e aver partecipato alla Resistenza. Amery racconta un aneddoto accaduto nel 1943, quando condivideva un appartamento coi suoi compagni partigiani. L’abitazione era confinante con una casa abitualmente frequentata da soldati nazisti. Un giorno, il rumore dei ribelli disturba la pennichella pomeridiana di un soldato, dall’altra parte del pianerottolo. Allora quest’ultimo sale e, trafelato e ancora mezzo addormentato, invoca un po’ di quiete. Scrive Amery/Mayer: «La sua protesta – e per me questo fu il lato realmente spaventoso della vicenda – avvenne nel dialetto della mia regione. Da molto tempo non avevo più udito quella cadenza e questo suscitò in me il folle desiderio di rispondergli nel suo stesso dialetto. Mi trovavo in una disposizione paradossale, quasi perversa, fatta di enorme paura e al contempo di improvvisa, familiare cordialità, perché quel tizio […] mi apparve d’un tratto come un familiare compagno. Non sarebbe stato sufficiente apostrofarlo nella sua, nella mia lingua, per poi celebrare tra compatrioti con una bottiglia di buon vino una festa di riconciliazione?». La morale della favola dovremmo ormai averla imparata sulla nostra pelle: anche tra chi parla il nostro stesso dialetto si nasconde un boia.
Giuliano Santoro


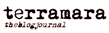

NESSUN COMMENTO